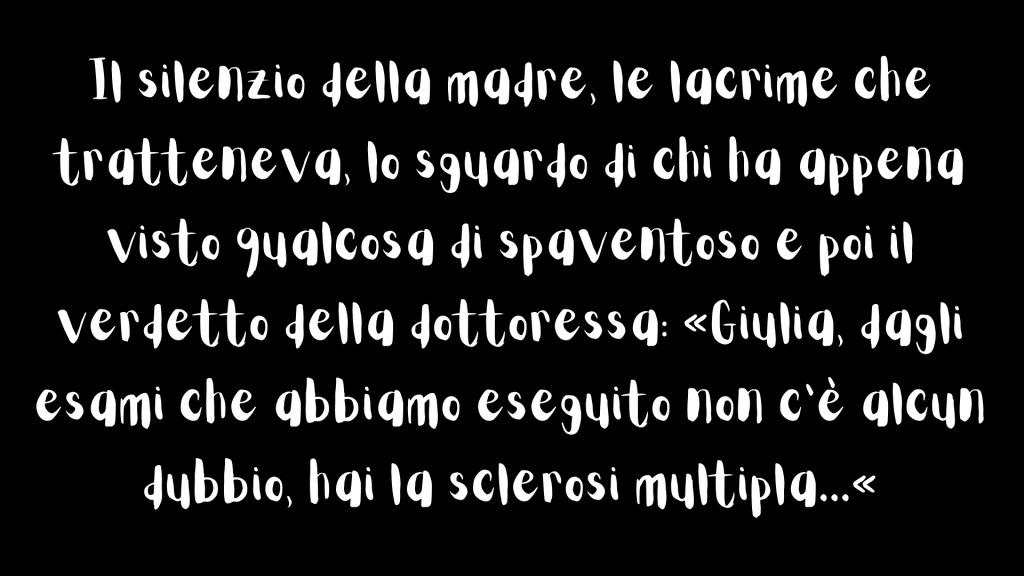Capitolo 1
Sara si sente morire dentro. Si appoggia alla ringhiera del terrazzo. Sedicesimo piano. Il vuoto la chiama. Milano è ai suoi piedi, le stelle le sorridono. Le mani strette al freddo metallo, si sporge mettendo alla prova il suo corpo che inizia a curvarsi. Il tacco si stacca dal pavimento, la pianta del piede si solleva, il respiro esita come se si stesse preparando a gridare. Il vento fa ondeggiare la gonna dell’abito di seta, scoprendo per un istante le gambe nude e lisce del colore dell’ambra. Sara sorride al pensiero che forse il suo sangue non si distinguerebbe nemmeno dalla stoffa. I piedi si staccano da terra, le braccia si tendono, il corpo teso si sbilancia verso il vuoto. Gli occhi fissano la strada, congestionata dal traffico, e i marciapiedi brulicanti.
«Così rischi di precipitare di sotto». Andrea l’afferra per un braccio e la tira indietro. «Magari, invece, scopro di saper volare».
«Sara…».
«Non sarebbe meraviglioso?». Nel dirlo, volge lo sguardo verso l’amico che la fissa con dolcezza. Solo i suoi occhi tradiscono una punta di preoccupazione, come se la sua mente avesse mandato avanti la scena di una caduta.
«Vieni dentro, ti stanno cercando».
«Vuoi dire che Simone mi sta cercando, giusto?». Andrea non risponde, non è necessario. Sara lo fissa, le palpebre immobili, poi rivolge lo sguardo al panorama. Cemento, luci artificiali. Oltre l’orizzonte: la luna, le stelle. Le cose più belle sono sempre in secondo piano. Prima il lavoro, poi il divertimento. Prima i compiti, poi il gioco. Prima il dovere, poi il piacere. Si rivede in quell’immagine da cartolina come fosse il mondo in cui dovrebbe stare; le dispiace solo che un vasto vuoto la divida da tanta bellezza: con un salto potrebbe vivere quel momento per sempre.
Capitolo2
«Arrivo» risponde, ma il corpo non si muove. Andrea si avvicina con passo calmo e la prende per mano. Sara si volta, disorientata, come se lui si fosse palesato solo in quell’istante. I loro visi sono molto vicini. Il marrone dei suoi occhi sembra tremare, o forse respingere uno scenario che non è annegare nell’orizzonte che ha cercato qualche istante prima. Andrea le sfiora una guancia, poi l’altra. L’accoglie tra le sue braccia e la trascina in un ballo lento, a piccoli passi, lontano dal vuoto, per ricondurla nella sala grande dove un trio di musicisti classici esegue un minuetto. È la sua festa. Chiude gli occhi, si abbandona all’amico d’infanzia e si lascia cullare come se si trovasse tra le braccia di sua madre e, in un attimo, si dimentica del suo desiderio di volare.
Essere attrice ha i suoi vantaggi: si può improvvisare ogni tipo di emozione e Sara affianca Simone con un atteggiamento da vera diva. Sorride fino ad allargare le labbra quanto quelle di Julia Roberts, stringe mani con convinzione, sorseggia champagne con grande eleganza e annuisce a ogni affermazione senza staccare la mano dal gomito del compagno e manager, che tiene le redini di ogni conversazione. A ogni domanda che le viene fatta, Simone inizia la risposta per lei. La sua carriera è alle stelle e il suo prossimo film, una produzione negli Stati Uniti, odora già di premio Oscar. Quella festa è la conferma che le porte di Hollywood si sono finalmente spalancate e Simone assapora già la sensazione di strisciare i polpastrelli su tanti Benjamins.*[1]
«Siamo ancora in attesa di sapere chi ricoprirà il ruolo dell’antagonista, ma ho un buon presentimento. Forse Sara lavorerà al fianco di DiCaprio, ma francamente vorrei un volto più fresco, tipo un Adam Driver. Insomma, avrà al suo fianco qualcuno che conti in quel di Hollywood, altrimenti non avrei mai acconsentito a valutare il copione». Mentre parla, agita il braccio, noncurante del flûte pieno di champagne che stringe nella mano destra. L’altra, invece, tiene stretta Sara come uno scimpanzé avvinghiato al suo padrone. «Oh, dovete venire a fare un giro sul nostro nuovo yacht, è un Somnio: più di duecento metri di lusso e comfort. Ho addirittura pensato di vendere tutte le proprietà per vivere definitivamente lì, ma i nostri piani, a breve, includeranno una cameretta speciale». Ingurgita lo champagne, poi stampa un bacio sulle labbra di Sara che lo accoglie impreparata: più che un bacio d’amore sembra un bacio rubato. Le persone attorno a loro gorgheggiano frasi fatte, complimenti e sorrisi al botulino; alcuni abbracciano Sara che reagisce a ogni gesto come fosse in differita. Dentro di lei qualcosa si è appena lanciato nel vuoto ed è morto.
[1] Benjamins: a indicare il biglietto da 100 dollari. Queste banconote, infatti, hanno stampato su un lato il volto di Benjamin Franklin.
Capitolo 3
Ad artificiose lusinghe e falsi abbracci, Sara reagisce con la stessa moneta: le braccia stringono con leggerezza le spalle di chi esulta felice per il suo radioso futuro. Le mani, quasi non avessero dita, si lasciano chiudere in strette possenti. Sotto quelle prese è come se la sua pelle si sgretolasse. Il cuore implora di uscire dal petto per scappare lontano, bombardato da un’ansia così forte da assottigliarle il respiro. Cammina, quasi per inerzia, al lato opposto della grande sala e, quando una porta si chiude alle sue spalle, rilascia un lungo respiro.
«Siediti sulla vasca».
«Sto bene in piedi».
«Siediti» ripete Simone, il tono di voce severo. Nel frattempo, le porge un bicchiere d’acqua riempito dal lavandino. «Che ti prende? Lo sai quanto è importante questa serata per noi». Sara manda giù piccoli sorsi alla volta, quasi temesse di annegare il cuore.
«Riprenditi, ci sono altre persone che voglio presentarti».
«Andiamo a casa, ti prego».
«Riprenditi e goditi la festa. Sono tutti qui per te. Non farmi fare figuracce!». La solleva con leggera irruenza e la conduce davanti allo specchio, spingendo il corpo contro il suo che preme forte contro il lavandino; uno strano déjà-vu emerge nella sua testa. La ringhiera… l’orizzonte… il vuoto.
«Rilassati, so di che cosa hai bisogno, ci penso io» e infila nella sua mano un pezzo di carta arrotolato.
«Non voglio».
«Devi rilassarti».
«Non voglio più farlo».
«Sara». Cambia di nuovo tono, proprio come una madre farebbe con una figlia disubbidiente. Le cinge la vita e con le labbra le sfiora una spalla in maniera maliziosa. «Ti conosco Sara, so di che cosa hai bisogno. Rilassati e lascia fare a me». Mentre lo dice, fa scorrere una mano lungo la gamba destra della ragazza. «Simone, andiamo a casa». La mano, ferma al ginocchio, risale stringendo un lembo di tessuto, scoprendo la coscia, poi le natiche. Sara si scosta, ma lui la preme ancora più forte contro il lavandino e la fa chinare fino ad avvicinarla alle due righe di polvere bianca che ha preparato; le avvicina la mano che stringe il pezzo di carta arrotolato. In quella posizione, Sara si sente come un animale nel territorio del cacciatore. Una voce dentro di lei le urla di smettere di subire, di fuggire lontano da lui e da una vita che non le appartiene, ma dove potrebbe scappare? Come potrebbe nascondersi dal resto del mondo? E mentre lo pensa, l’irruenza di Simone entra ed esce dal suo corpo. Sara aspira forte, emettendo un debole gemito. Lui le accarezza il viso e si muove su di lei come se galoppasse una giumenta imbizzarrita che si lascia a mano a mano ammansire. «Ancora un’altra» e Sara si ritrova con il viso sul freddo marmo del lavandino. «Tutta quanta!». Aspira forte, di nuovo, lecca ciò che rimane sulla superficie e aspetta che tutto finisca.
Il riflesso allo specchio mostra una ragazza che non riconosce più. Mentre, dietro di lei, Simone si riveste con l’atteggiamento di un marito infedele pronto a dimenticare l’amante fino al prossimo incontro, Sara fissa se stessa. Mamma, papà, dove siete?
«Esci tra qualche istante e raggiungimi con due calici di Broël & Kroff». Mentre chiude i bottoni della giacca, fermo all’ingresso, si gira verso Sara: giocherella con le punte dei suoi ricci vaporosi, il cui colore ricorda quello delle castagne in autunno, gli occhi persi altrove. La fa voltare, la schiena preme contro le fredde mattonelle. Le prende il mento tra l’indice e il pollice, è rude. Le stampa con forza un bacio sulle labbra. Sul viso appare un sorriso che a Sara pare più un ghigno.
«Ancora un’ora, poi andiamo a casa».
«Va bene».
«Fai la brava fino ad allora».
Capitolo 4
La musica arriva alle orecchie di Sara come un getto d’acqua fredda. L’invadente presenza di Simone l’ha temporaneamente privata di ogni senso. Respira profondamente, pronta a riprendere il ruolo di attrice “sempre felice e contenta” ma quando abbassa la maniglia si blocca. La parola cameretta riaffiora alla memoria con violenza e una sorta di gelo cala nel piccolo bagno, facendole venire la pelle d’oca. Simone è un abile oratore, lo è sempre stato. Ciò che vuole lo ottiene, sempre. E forse è riuscito nel suo intento anche poco fa, lasciando dentro di lei una traccia che potrebbe prendere forma in nove mesi e che la legherebbe a lui per sempre. Le telefonate notturne, gli appuntamenti in agenda fissati senza preavviso, la fretta di andare a Hollywood: nella mente di Sara emerge un flashback che assomiglia all’epilogo di un libro, in cui ogni azione trova il suo movente. Se quella sera Simone avesse fatto centro, al termine delle riprese del film, lei si ritroverebbe come un uccello in gabbia camuffata da uno sfarzo smisurato. Il cuore, ridestato dopo un breve sonno indotto con la forza, riprende a bombardarle il petto come la pallina di un flipper e scoppierebbe all’istante se non fosse per le voci di Andrea e Simone che la riportano alla realtà. Spalanca la porta e si lancia nel corridoio. Poco distante, vede i due uomini discutere animatamente. Una donna cerca di dividerli.
«Ti ho detto che mi occupo io di lei!» dice Simone gonfiando il petto e avanzando di un passo verso Andrea. Sara osserva l’amico, nelle mani tiene la sua pelliccia di zibellino, al suo fianco la moglie.
«Simone, calmati. Gli ho chiesto io di portarmi la pelliccia. Prima ero sul terrazzo, sentivo freddo e…». Non prosegue la frase, lanciata come amo per vedere se il pesce abbocca a una scusa tanto banale quanto falsa. Si avvicina all’amico, lo ringrazia e si stringe a Simone; per quella sera non vuole altri drammi. «Andrea, tu e Miriam andate pure, ci vediamo domani a colazione, come da accordi». L’amico cerca di fermarla con lo sguardo, vuole portarla via dalla festa, ma Sara è più lesta e trascina Simone in direzione della grande sala. Appoggia la pelliccia su una poltrona e prende al volo due flûte dal vassoio del primo cameriere che le passa di fianco. Ne porge uno a Simone e gli chiede chi siano le persone che deve conoscere. Lui mostra un sorriso compiaciuto, ma non sa che ora è lui a esser stato ammansito.
Il tempo scorre alla stessa velocità di come si spostano i ghiacciai e i pensieri di Sara la tormentano al punto da farla quasi svenire. Trova conforto rifugiandosi di nuovo nel terrazzo: un piccolo premio che Simone le concede per aver tenuto testa a diverse conversazioni in maniera magistrale. Questa volta, però, non raggiunge la ringhiera. Si adagia a un muro, nell’unico punto cieco di quell’area e gode della solitudine che la circonda. Il vociare, proveniente dall’interno, è un insopportabile sottofondo che tollera sempre meno, fino a quando non coglie un altro rumore: quello che emette un ascensore quando raggiunge un piano. Incuriosita dalla novità, si scosta dal punto cieco e allunga la testa. Alcuni scalini portano a una piccola passerella e a un ascensore da dove escono due uomini che spingono un carrello con sopra due casse di legno; d’istinto, s’infila nell’ascensore prima che le porte si richiudano. Più si allontana dalla festa, più sente i polmoni ossigenarsi e il cuore rallentare il battito. All’apertura delle porte, esita qualche secondo, terrorizzata all’idea di trovarsi di fronte a Simone, piegata a terra dal dolore per un pugno allo stomaco. Nel suo lavoro deve essere sempre impeccabile: un livido al viso può compromettere le riprese di un film, ma un vile colpo allo stomaco si limita a farle rigettare quanto appena ingerito.
Si muove nel buio del pian terreno, guardinga, attraversando quella che pare essere la continuazione di un’area riservata allo staff; a un metro da lei, una porta tagliafuoco. Si affretta a raggiungerla ma, d’improvviso, la sua attenzione è richiamata da un giaccone nero appeso a un gancio. Si assicura di essere sola, poi lo afferra e lo indossa alla bell’e meglio essendo di tre taglie più grande di lei. Nel muoversi con agitazione, mentre si avvia verso l’esterno, rallenta il passo al tintinnio che deduce provenga da una delle tasche del giaccone. Sfila un sacchetto di plastica bianco di un noto supermercato e al suo interno scopre una decina di mignon di vodka e whiskey. Ripone il sacchetto al suo posto e supera la porta tagliafuoco: l’impatto con l’aria fresca e il totale silenzio, la rinvigoriscono. I lampioni illuminano un ambiente che sembra aver preservato il lusso della festa: l’erba delle aiuole tagliata al millimetro, bossi dalla perfetta forma tonda spuntano da imponenti vasi di terracotta; persino l’asfalto sembra essere stato pulito in suo onore. Qualcuno avrà notato la mia assenza?
Gli uomini che aveva visto poco prima, sbucano nel parcheggio all’improvviso e Sara si nasconde giusto in tempo per non farsi notare.
«Abbiamo scaricato tutto?».
«Sì, anche se nemmeno sapranno quanto Broël & Kroff hanno a disposizione. Figurati, lo dimenticheranno in quel costosissimo attico in cui si stanno rincoglionendo di chiacchiere inutili».
«E noi torniamo e ce lo portiamo a casa!».
«Sì, come no, e poi ci ritroviamo senza un lavoro!».
«Sai che scherzo, no?».
«Sì, sì… ci vediamo il prossimo mese, allora?».
«Perché? Cosa c’è il prossimo mese?».
«La festa di fidanzamento di Sara West con il suo manager».
«Ah sì, mi hanno accennato qualcosa. Sempre tra ricconi si sposano, eh?».
Ridono, poi uno dei due uomini ripone il carrello nel furgone e scende per fumare una sigaretta. Sara, le braccia incrociate al petto per tenere ben chiuso il giaccone, tende l’orecchio per ascoltare meglio la loro conversazione. Fidanzamento?, pensa trattenendo un singhiozzo, immaginando un’invisibile lama puntata alla gola. Ciò che ha appena sentito la getta nello sconforto: niente di ciò che dice o fa è una sua scelta. Ogni volta, in un modo o nell’altro, è Simone a battere il punto vincente.
«E ora dove sei diretto?».
«A Valli, un paesino sperduto in Veneto».
«E cosa diavolo devi fare laggiù?».
«Ho accettato un lavoretto extra. Devo lasciare dei mobili a un tizio. Ti dirò la verità, appena mi hanno detto quanto pagavano, ho detto di sì. Per quel che mi riguarda, potrei trasportare anche cadaveri! Parto già ora perché mi vedo con la mia ragazza. Ha saputo che vado lì e vuole trascinarmi a vedere un posto che definisce magico, tipo una cascata, non ricordo. Francamente, non me ne frega niente: voglio solo fare festa tra le lenzuola, non so se mi spiego…».
«Eccome se ti spieghi, amico. Ma poi che cavolo ha di magico una cascata? Valle a capire te le donne».
«Mah, dice che è un posto così magico che ti va venire voglia di volare».
Sara non ha idea di che ore sono e da quanto quel tizio sta guidando. Si è fermato solo una volta, forse in una stazione di servizio per fare rifornimento. L’unica cosa che nota è una diversa inclinazione della strada perché spesso il corpo preme contro uno dei tanti mobili nel furgone. Non è mai stata nel luogo che sta per raggiungere, tantomeno si è mai nascosta in un furgone per sfuggire a una vita che la soffoca da troppo tempo. E non si chiede nemmeno più come potrebbe sopravvivere, perché una folle idea sta prendendo forma nella sua testa e le piccole bottiglie di alcool trovate nella tasca del giaccone la stanno alimentando.